Prologo
Bach Mozart Beethoven.
La storia gira sulle triadi. La storia è fatta di triadi.
Lenin Stalin Mao. Baudelaire Rimbaud Verlaine. Il mondo vuole le triadi: banale dirlo, ma e cosi. Inferno purgatorio paradiso. Tonica caratteristica dominante. Kant Hegel Spinoza. Padre figlio spirito santo.
La vita – anche quella è fatta di triadi. Battesimo comunione cresima. Elementari medie superiori. Moglie marito amante. Sinistra centro destra. Sesso droga rock ’n’ roll. Sesso suino sciampagna. E via dicendo.
Perchè l’uno va bene, interessa, affascina nel suo isolamento solipsistico; ma non combina, non rotola, non interagisce, non crea frizioni, non innesca dinamiche dialettiche degne di nota.
Il due è piatto. Piattume. É l’uno che si specchia e si annulla simmetricamente in se stesso. Il due e la coppia. Bianco nero. Marito moglie. Tv pantofole. Superiore sottoposto. Ufficio casa. Casa chiesa.
Maschio femmina. M’ama non m’ama.
Il tre però è esattamente 2+1, che essendo (pur cosi vicini) opposti, antitetici e ineluttabilmente inconciliabili, messi insieme fanno un’entropia pazzesca. Simile a un legame chimico schizzato. Simile alla settima che Monteverdi osò per primo prendere di salto, facendo incazzare come bestie il papa e i suoi soci.
Col tre la giostra si muove. La dialettica riparte, le combinazioni si moltiplicano, i contrasti rinverdiscono e le gelosie si ravvivano. Il movimento si energizza, i rapporti intrinseci ed estrinsechi riprendono a turbinare con frizzante instabilità. Le alleanze si creano. Le maggioranze
fluttuano. L’effervescenza turbina.
Insomma, una gran botta di vita.
Non era questo però il caso della nostra triade, che pur condividendo con le altre diversi tratti caratteriali (inconcludenza, grandi ideali impraticabili, simpatie per le sostanze stupefacenti) e biografici (frequente disoccupazione, sottoccupazione, occupazione sottopagata, sottoccupazione sottopagata), non sarebbe mai comparsa su alcun testo scolastico. Anche se a suo modo e in altre circostanze storiche avrebbe potuto combinare qualcosa di buono per l’umanità. Ma questo è un altro discorso, e per ora lasciamolo.
Fatto sta che le energie creative della nostra triade oramai languivano. I cambiamenti sembravano non voler bussare più alle porte delle loro dimore spirituali. Insomma: come per chiunque si sia addentrato nei trenta già da un po’, incombeva il rischio della dolceamara routine esistenziale.
Quando – inatteso se pur banale, dolce se pur scontato – un cambiamento giunse.
Anzi, tre cambiamenti giunsero. Uno per ogni componente della nostra triade.
Del nostro trio.
Biffi Conficconi Pazzaglia.
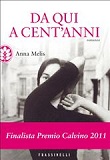
 Einaudi
Einaudi invio in corso...
invio in corso...
Visita il nostro canale Youtube
Visita la nostra pagina Facebook
Visita la nostra pagina Twitter
Visita il nostro profilo Instagram