
Intervista di Ella May – settembre 2016 (con Sinatti) – INEDITO
Illustrazione di Davide Lorenzon
Elisabetta Pierini, classe ’64, vive a Fermignano e lavora presso l’università di Urbino come assistente tecnico chimico analitico. Estranea al mondo dei social network, madre di quattro figli, amante della bicicletta e divoratrice di libri, Elisabetta è senza dubbio un’esploratrice appassionata dell’animo umano. Il suo genuino interesse per la psicologia e per le tortuose pieghe della psiche pervade ogni pagina del suo romanzo, intitolato quasi fiabescamente L’interruttore dei sogni. Vincitrice della 29° edizione del Premio Italo Calvino in ex aequo con Cesare Sinatti, la Pierini ha dimostrato di sapersi addentrare con sensibilità e cognizione di causa nei tormenti di una famiglia disfunzionale e traballante, attraverso lo sguardo limpido e sognatore di una bambina come tante, eppure unica nel suo modo di affrontare la quotidiana infelicità.
1) Per parlare del tuo romanzo forse dobbiamo partire dall’ambientazione: perché hai scelto proprio un’anonima periferia urbana?
Ho pensato a un luogo senza volto, senza personalità, con case uguali come sono le zone residenziali dei paesi e delle piccole città in cui vivo, fatte di case a schiera con un giardino minuscolo, uguali alle altre per metratura e forma. Cambia solo il colore da una schiera all’altra. Queste case sembrano sancire un’esigenza di uguaglianza socio-economica che fa risaltare per contrapposizione la diversità della famiglia di Eva, la bambina della mia storia. Infatti, oltre alla ricchezza che sancisce il ceto sociale, esiste anche una ricchezza affettiva. E la malattia mentale, determinando l’impossibilità di stabilire legami, rappresenta lo zero assoluto in questa diversa scala di misura.
2) In questo “luogo senza volto” vive appunto Eva, la piccola protagonista del romanzo. È stato difficile immedesimarti in una bambina di dieci anni?
Ho quattro figli (il più piccolo di loro ha nove anni), ognuno con tutta una serie di amici che hanno frequentato e frequentano casa mia. Ma anche prima di avere figli, cioè prima di sposarmi, tenevo gruppi in parrocchia. In genere i miei romanzi non sono pensati a tavolino, direi piuttosto che nascono dal nulla. Sono partita dal primo capitolo, da lì piano piano si è materializzato il resto. Di solito faccio una prima stesura, che poi cambio completamente. Un romanzo è per me come un’arrampicata su una parete liscia di roccia. Ogni volta cerco nuovi appigli e non so mai quale strada prenderà la storia. In genere ci capisco qualcosa dopo due o tre stesure e a quel punto inizio a lavorarci usando anche la testa, cioè ragionando sui passaggi. In un primo momento invece la testa non mi serve. Perciò spiegare perché scrivo quello che scrivo non è facile. È vero che alcuni personaggi vengono da persone che conosco, però di solito faccio un frullato della realtà umana con cui sono o sono stata in contatto e ne riassemblo i frammenti. I fatti invece li invento quasi sempre. Non riesco a pianificare una storia a tavolino, non è nella mia natura e nemmeno riuscirei a scrivere un romanzo autobiografico. Non potrei farlo anche perché ho pochissimi ricordi. Ma soprattutto non mi interessa percorrere un’autostrada di scrittura, preferisco le strade bianche.
3) Sia Eva che sua madre Alma hanno un rapporto a tratti “falsato” con la realtà: quali sono le differenze tra il modo adulto e il modo infantile di rapportarsi con l’immaginario? E cos’è “l’interruttore dei sogni”?
La malattia mentale di Alma taglia il rapporto con la realtà di netto, rende impossibile un rapporto empatico e affettivo con le persone impedendo ogni comunicazione non verbale. La comunicazione verbale resta legata alla capacità della bambina di aderire alle allucinazioni e ai disturbi dell’ideazione della madre. Ma inseguire un rapporto dove non c’è possibilità di empatia è come inseguire un’altra illusione. I rapporti di Eva con il fratello immaginario e con “l’uomo con la valigia” sono rapporti più veri e ricchi di quello che ha con la madre. La bambola chiamata “la signora” è invece una proiezione della madre; ci racconta come la bambina vorrebbe che fosse sua madre, se riuscisse a occuparsi di lei. Pure questa proiezione però, come la madre vera, è incapace d’affetto. Così Eva, per compensazione, ha sviluppato una forte capacità di empatia, dovuta anche alla necessità di occuparsi dei suoi genitori. È piuttosto comune che in famiglie fortemente disturbate ci sia un ribaltamento dei ruoli e che i figli, anche molto piccoli, siano iper-responsabilizzati e “chiamati” a occuparsi dei genitori. Nell’immaginario infantile il sogno consiste nella fantasticheria a occhi aperti, un metodo veloce per evadere dalla realtà; nell’adulto il sogno a occhi aperti è sostituito dal desiderio. Mentre il sogno a occhi aperti serve al bambino a sopportare la realtà, il desiderio ha in sé l’esigenza del cambiamento, del sovvertimento, e spesso è illusorio. Mentre il bambino mette in atto strategie protettive, spesso l’adulto si suggestiona e si autoinganna. “L’interruttore dei sogni” è la capacità di chiamare il sogno in soccorso quando la realtà è insopportabile. È il fiammifero della piccola fiammiferaia che trasfigura le cose e crea l’oasi nel deserto. Il sogno di Eva è soprattutto un salvagente. Il fatto che sia un salvagente può far venire in mente che la bambina annegherà prima o poi, ma qualcuno potrebbe arrivare in tempo a salvarla. Il sogno fa sopravvivere, al momento presente. Poi non sta più al sogno fare il resto.
4) Quella di Eva potrebbe essere considerata una “storia di un confine”: racconta il confine tra la periferia e la città o tra la periferia e la campagna, il confine tra reale e irreale, il confine tra infanzia e adolescenza, il confine tra felicità e infelicità. Cos’è per te il confine?
“Confine”, “limite”… Sono parole che invitano all’oltre, al passo in più. Mi fanno pensare a quando si credeva che la Terra fosse piatta e che il mare finisse all’improvviso nel nulla. Quei pochi metri tra il mare e il nulla sono uno spazio ricchissimo. Il romanzo che sto completando ora è tutto scritto nella zona di confine. Del resto il confine tra reale e irreale è tracciato con il pennarello indelebile solo per chi è rigorosamente non credente e ha un approccio alla realtà mediato dai cinque sensi. Ma ci sono troppe cose non spiegabili con i cinque sensi e l’universo è pieno di mistero. Il mondo stesso degli affetti non passa soltanto per i cinque sensi. Mio padre, il giorno prima di morire, era perfettamente lucido e parlava con tutti noi delle solite cose, ma allo stesso tempo vedeva anche il fratello già morto, che gli ha spiegato per filo e per segno cosa c’è di là. Mio padre ci ha detto di avere capito tutto e di essere tranquillo. Eppure lui non era un credente ed era una persona molto razionale. E di sicuro non sapeva che sarebbe morto il giorno dopo.
5) Qual è il tuo personale “interruttore dei sogni”?
La lettura e la scrittura sono sicuramente un modo rapido per passare da un mondo all’altro. Io però non ho perso la capacità infantile di fare sogni a occhi aperti, lo ammetto con un po’ di vergogna.
6) Parlaci del tuo rapporto con la scrittura: hai avuto altre esperienze prima del Premio Italo Calvino?
La scrittura è sempre stata per me il Salvagente. È la stanza mentale che si trova nel punto di frontiera, sul confine tra felicità e infelicità, tra realtà e irrealtà, tra l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta. È una stanza situata in una zona sospesa, in una zona pericolosa che in qualche modo riesce sempre ad ammortizzare miracolosamente gli urti con la vita e con la realtà, soprattutto quando la realtà si fa soffocante e ci fa vedere solo il muro di fronte. Se la Terra fosse davvero piatta, la scrittura sarebbe la stanza costruita nel punto esatto in cui finisce il mare, il punto esatto dove oltre non c’è più niente.
Tra le esperienze precedenti al PIC posso citarne due: RicercaBo è stata la mia prima incursione nel mondo letterario e Donne di Penna è stata l’occasione per rompere il ghiaccio e provare a parlare in pubblico di un mio romanzo. Ho sudato freddo in tutti e due i casi, ma sono state due belle esperienze, certo per me faticose.
7) E poi è arrivato il Premio Italo Calvino. Hai partecipato a più di un’edizione: raccontaci il tuo lungo percorso.
Ho mandato ben cinque manoscritti al PIC, perché desideravo confrontarmi con qualcuno del mestiere che potesse darmi un’idea della validità e dei punti deboli del mio lavoro. Le prime schede mi sono state utili per capire come correggere il tiro. Non ho rapporti con l’ambiente letterario e volevo dei consigli veri, professionali. Del resto con gli editori è impossibile parlare, ricevono troppi manoscritti. Ho smesso quasi subito di rivolgermi a loro, credo che solo Moresco sia riuscito a farsi rispondere da un editore.
Penso che la mia soddisfazione più grande sia stata la finale della 27° edizione del PIC, ottenuta con il manoscritto intitolato Notte. Quando Mario Marchetti (oggi presidente dei Premio) mi ha telefonato, stavo guidando e ho rischiato di andare fuori strada per l’emozione. La vittoria della 29° edizione poi è stata del tutto inaspettata; man mano che chiamavano i finalisti e il mio nome non arrivava, mi cresceva dentro la paura. Non so perché in quel momento mi ha preso il panico, mentre la volta precedente ero al settimo cielo. A casa poi ho letto i giudizi di Angelo Guglielmi e di Paola Capriolo, e ho pensato che anche se non dovessi mai trovare un editore, potrebbe benissimo bastarmi la soddisfazione delle parole gentili che mi hanno dedicato.
8) Cosa è cambiato dopo il PIC?
Per ora non ci sono stati né contratti né progetti, se non quello di cercare un editore per L’interruttore dei sogni e per Notte, che ho riscritto e a cui sono molto legata. Mi è stato detto che una casa editrice importante aveva prenotato “L’interruttore dei sogni” nei primi giorni dopo la premiazione, ma poi hanno cambiato idea. L’entusiasmo dell’editor di quella casa editrice per il mio romanzo mi ha fatto comunque molto piacere, anche se non ha portato a risultati concreti. Speriamo che prima o poi un altro editore si faccia avanti.
9) Tu sei cambiata dopo la vittoria?
Sono sempre io, incorreggibile. Non basta una vittoria a cambiarmi, anche se l’apprezzamento del Premio Italo Calvino per il mio lavoro ha significato moltissimo per me. Ero in un periodo della mia vita in cui avevo un estremo bisogno che qualcosa mi andasse bene. Io leggo molto, credo che sarei in grado di farmi un’idea della qualità di un romanzo anche dalla lettura di poche pagine. Ma su quello che scrivo io, navigo al buio. In genere non mi fido molto del mio giudizio. Mi fido solo se è negativo.
Comunque sarò sempre grata al PIC per la fiducia che mi è stata dimostrata. Il Premio è gestito da persone che conoscono alla perfezione il mondo letterario e sono tutti molto scrupolosi nel lavoro di selezione. Loro non guardano solo a ciò che è commerciale e a cui possono trovare facilmente un editore. Credo che ormai sia impossibile arrivare a una casa editrice senza il tramite di un concorso importante, soprattutto se non si scrive esattamente in linea con il gusto attuale. Certo, in tutto ci vuole anche la fortuna.
10) In chiusura te la senti di dedicare un pensiero a Cesare Sinatti, vincitore come te della 29° edizione del PIC?
Cesare è poco più grande dei miei figli; è un ragazzo intelligente e determinato che sta puntando molto sulla sua formazione culturale. Non posso dire di conoscerlo bene, spero che avremo modo di frequentarci e di frequentare insieme il mondo letterario. Lo vedo un po’ come il mio opposto. Lui quando inizia a scrivere deve avere tutto il progetto pronto e anche negli studi mi pare che abbia le idee molto chiare. Io invece sono il tipo che cammina sempre nel buio, che spesso non ha idea di dove andrà e cosa farà, guidata soltanto dalla luce fioca di una candela. Gli auguro di avere successo e di vivere tante esperienze interessanti.
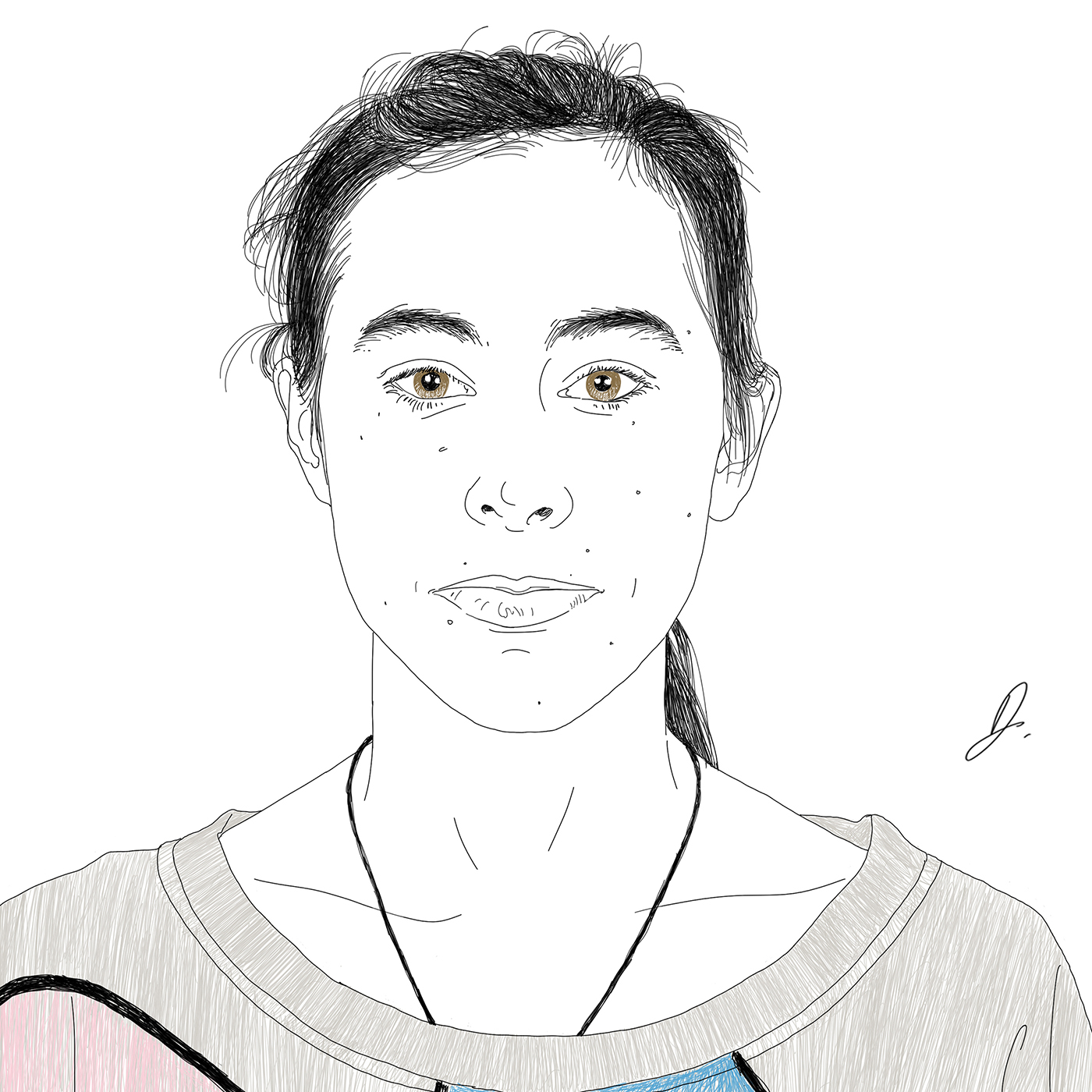













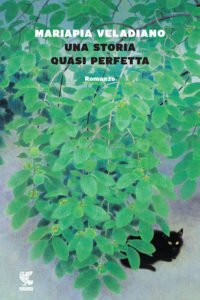
 invio in corso...
invio in corso...
Visita il nostro canale Youtube
Visita la nostra pagina Facebook
Visita la nostra pagina Twitter
Visita il nostro profilo Instagram