
Intervista di Ella May – febbraio 2017
Illustrazione di Davide Lorenzon
Valerio Callieri è un tipo che rimane impresso: il sorriso un po’ sospeso, lo sguardo diretto e l’espressione oscillante tra lo svagato e l’attento che porta a chiedersi cosa stia vedendo mentre guarda il mondo.
Classe 1980, nato e cresciuto a Roma e dintorni, ha deciso di assecondare la sua vocazione di scrittore durante un ricovero ospedaliero che lo ha costretto a fermarsi e a fare i conti con la sua passione di sempre. Quando non scrive, legge; quando non legge, corre. Si definisce “la banalità fatta persona”, ma lui è tutto fuorché banale e il suo esordio ne è la dimostrazione più lampante.
Vincitore (in ex aequo con Cristian Mannu) della 28° edizione del Premio Italo Calvino, è arrivato per direttissima alla Feltrinelli, che lo scorso 12 gennaio [2017] ha pubblicato il suo Teorema dell’incompletezza. L’opera prima di Valerio è un romanzo teso e toccante, in bilico tra giallo e noir, intriso di storia, sostenuto da una raffinata immaginazione, ricco di sfumature che compongono (e ri-compongono) uno dei volti più sofferti dell’Italia appena passata e, speriamo, tutt’altro che dimenticata.
1) La storia che ci racconti è incentrata su due fratelli e sul loro rapporto. Due figure diverse nate dalla medesima radice, due personaggi che potremmo definire “archetipi”.
Di uno di loro non veniamo mai a sapere il nome: è il narratore. L’altro invece è Tito. Sono figli della stessa assenza. Sia il narratore che Tito non sono fieri della vita del padre, un barista che governava con le risate un pezzo di periferia romana, una persona apparentemente innocua e senza desideri. Entrambi però ne hanno ereditato alcune caratteristiche. I due fratelli si ritrovano dopo cinque anni di silenzio proprio grazie a un indizio che riguarda l’omicidio del padre. Diventerà un’occasione per scoprirne il passato, ma soprattutto un percorso emotivo. Come si supera il dolore? Un lutto? Il narratore ha ereditato un’allegria che ha tinto di malinconia. Un’allegria con cui cerca di allontanarsi dalle questioni “pesanti” della vita, etiche, politiche, metafisiche. Una barriera ironica, diciamo così, con cui mantiene la sua indolenza. Tito invece è figlio di una forza strana (nascosta negli anni sconosciuti del padre) che diventa una fede ferrea. Un poliziotto con una fede senza pietà, senza colpa e senza peccato. Una fede lontana dalle religioni a cui non crede. Adesso mi viene in mente, parlando di archetipi, che è un guerriero che vuole diventare re. Un senex bianco: crede nella lealtà, nel futuro e nella responsabilità. Non concepisce la debolezza e forse ha troppa fiducia in se stesso. I due fratelli entreranno spesso in collisione ma, ecco, almeno per me è veramente difficile parteggiare per l’uno o per l’altro e spero che lo sia anche per l’eventuale lettore. La storia li porterà in territori che non avevano mai desiderato percorrere e che rivelerà la loro natura profonda.
2) Come hai costruito il protagonista-narratore?
È fondato su una ferita di malinconia. La morte del padre lo ha privato della vitalità e dello sguardo verso il futuro. Lui non lo sa, ma è veramente un Telemaco in attesa di un ritorno impossibile. Anche se poi, in qualche maniera, dalla riva del mare qualcuno arriverà: il fantasma paterno. Il protagonista è quasi sempre ironico, un atteggiamento che gli permette di evitare il confronto con un possibile amore, Elena, e con ogni impegno reale. Ci sono delle “cavallette” nel suo cervello che amministrano la sua indolenza e con le quali ha imparato a convivere. Il problema più grande è che gli eventi lo metteranno a contatto con dinamiche quali il Conflitto, l’Amore, la Vendetta, lo Scavo Interiore. La Storia italiana lo chiamerà con la voce del fantasma e gli spalancherà gli occhi sulla fabbrica torinese degli anni ’60, le lotte operaie, le stragi di stato e il mistero del Memoriale Moro. Così come il fratello Tito lo sfiderà continuamente sui fatti di Bolzaneto e del G8 di Genova. Il protagonista capirà che non può essere un eroe da tragedia greca, come Oreste o Edipo, ma dovrà comunque scegliere e accettare l’imperfezione (l’incompletezza del titolo, appunto) e superare la sua “comoda” malinconia.
3) Le vicende narrate nel tuo romanzo ci portano tra le strade di Roma, in particolare a Centocelle. Cosa rappresentano per te questi luoghi?
Centocelle per me è innanzitutto un luogo dell’infanzia, però la scelta di ambientare qui la storia è dovuta alle sue caratteristiche contraddittorie. Da una parte è stato un serbatoio periferico di militanti dei movimenti degli anni ’70 e della lotta armata. Dall’altra è anche il luogo di quella forza di cui scrive Pasolini ne Le ceneri di Gramsci: “attratto da una vita proletaria a te anteriore, è per me religione la sua allegria, non la millenaria sua lotta: la sua natura, non la sua coscienza”. Un luogo in cui convivono la militanza severa e l’ancestrale allegria, la connivenza con il terrorismo e il qualunquismo spensierato, per banalizzare. Un luogo che esprime la ferocia e l’ironia della Storia.
4) Tutto il racconto ruota intorno alla ricerca che il protagonista, assieme al fratello, mette in moto per ricostruire la storia segreta del padre, scoprendo che forse non era l’uomo che loro credevano.
Sì, insieme al fratello Tito cercano di ricomporre i pezzi della vita del padre prima della loro nascita. Tito ha delle esigenze professionali, da poliziotto, il protagonista viene invece “investito” e spinto in questa missione dal padre. Al di là degli obiettivi della storia, quello che secondo me è interessante è il tema dell’eredità emotiva. Entrambi accettano la loro provenienza e sono costretti, in maniera differente, a farci i conti senza più rifiutarla con il consueto istinto adolescenziale. Questa è stata anche una porta d’accesso per me. Una scoperta emotiva durante la scrittura.
5) Come “controparte” di questi due caratteri maschili hai creato due donne, che vivono e si muovono in un alone di mistero. Chi sono Elena e Clelia?
Sono due figure che spero di essere riuscito a delineare sfuggendo agli stereotipi sul femminile che si attivano spesso nelle narrazioni più disparate. Non sono ammaliatrici, né angeli del focolare e neanche uomini con la “a” finale (qui si apre il “caso Andrea”, ma lasciamo stare…). Elena è un’amica del protagonista, un matematico che disvela le emozioni con roba che dovrebbe essere gelata e cerebrale come i teoremi della logica. Elena è fondata su una sofferenza di fondo a cui gli uomini intorno non hanno accesso e che lei non rivela. È un personaggio che intuisce e rende semplice la complessità, senza mai compiacersi di questa sua abilità. Clelia invece è un mistero legato al mondo del padre. Lei ha un obiettivo molto più definito nella storia e porta addosso i segni di conflitti politici laceranti. Porta con sé la morte e il tradimento e vuole provare a cambiare il suo passato, per quanto possibile. Entrambe sono figure centrali, in grado di prendere le redini della storia senza aspettare che qualcuno conceda loro il permesso. Due donne autonome in maniera completamente diversa.
6) Per quale motivo hai scelto di rievocare questo particolare volto dell’Italia?
Egoisticamente parlando, ti dico che ho scelto di raccontare questo periodo perché sono un grande appassionato della storia degli ultimi sessant’anni. Poi credo che ci sia l’esigenza di continuare a riscrivere la nostra storia all’interno di filoni che non siano solo quelli del noir con sfondo complottista e quindi consolatorio, oppure con uno sguardo lontano e freddo in cui il lettore progressista riesca subito a individuare il Bene e il Male grazie all’apparato didascalico fornito dall’autore. Siamo (stati) abitati da forze storiche potenti e tragiche. Ognuna portatrice di ragioni che hanno coinvolto migliaia di persone. Vogliamo parlare del fascismo, del brigatismo e dello stragismo di stato? Dobbiamo essere in grado di dare voce realmente a questi spigoli appuntiti. Dobbiamo provare ad abitare territori estremamente scomodi. Secondo me, la letteratura è il solo luogo in cui possiamo farlo. “Dobbiamo” farlo, perché è l’unica possibilità di comprendere posizioni diverse che, guarda caso, a un certo punto ritornano nella Storia a presentarti lo scontrino, come possiamo vedere un po’ ovunque oggi. E dubito che la mostrificazione di queste forze storiche possa essere una via di uscita.
7) Se tu dovessi etichettare questo romanzo definendolo per genere, in quale scaffale della libreria lo metteresti?
Non lo so… Credo che all’interno ci siano gli stilemi e le tecniche del romanzo popolare e di vari generi. Al noir, al giallo e allo storico, forse aggiungerei il fantasy. Non so se esiste uno scaffale specifico. Però, ecco, mentre ti rispondo penso che alcuni dei romanzi che ho amato di più (come Amatissima di Toni Morrison o Il maestro e Margherita di Michail Bulgakov) e che riescono a descrivere in maniera ineccepibile e profonda lo schiavismo dei neri negli Stati Uniti e la burocrazia sovietica, lo fanno utilizzando elementi sovrannaturali, magici, con una forza narrativa che il realismo sociale, per capirci, non riesce a raggiungere. Non è troppo importante capire quale sia il genere, ma cosa si vuole raccontare. Bisogna farlo con ogni mezzo necessario e adatto a raggiungere la verità profonda (che non è la semplice realtà).
8) Parlaci della tua esperienza con la Scuola Holden.
Tanto per cominciare, ci sono andato a causa di una polmonite. Stavo facendo tutt’altro lavoro, un lavoro attinente al mio ramo di studi che è la sociologia della comunicazione. Lavoravo all’interno di un’azienda che studiava la comunicazione di altre aziende e dei competitor, curandone l’immagine sociale, diciamo così. Non era male. Però, quando mi sono ammalato, guardando il soffitto grigiastro del policlinico Umberto I per una decina di giorni, ho capito che se non mi fossi buttato a capofitto nel mio desiderio non ce l’avrei mai fatta, o comunque avrei finito per non provarci nemmeno e sarei diventato un burbero signore che ripete sempre “se avessi potuto”. Quindi la Holden mi sembrò la soluzione ottimale (avevo anche piani di riserva, come cercare un lavoro non cognitivo e nel frattempo frequentare corsi di scrittura nel fine settimana). Visto che mi hanno pure concesso la borsa di studio, ho scelto di andarci. Così ho imparato un atteggiamento “alla Holden” e credo di capirlo adesso più di prima. Vedere persone in carne e ossa che scrivono per mestiere e ti mostrano alcuni strumenti del loro lavoro diventa la prova che si può fare. A costo di tanti sacrifici, solitudine e perseveranza, ma si può fare. Fornisce anche un’armatura contro il mondo di fuori, che tende sempre a svalutare la letteratura o a vederla come rifugio di bohemien che osservano la luna cercando l’ispirazione.
9) E poi, il Premio Italo Calvino.
Senza esagerare: a me il Calvino ha cambiato la vita. Perché poi uno si scorda un sacco di cose, tipo l’incredibile e silenzioso malessere che ti porti dentro mentre scrivi e scrivi e riprovi a scrivere senza nessuna legittimazione esterna. Un malessere che non riveli mai pienamente perché, almeno nel mio contesto di riferimento, fa un po’ ridere: cioè, tu sei preoccupato perché nessuno ti fa la carezza di riconoscimento mentre “là fuori” non c’è uno straccio di lavoro e la gente muore per malattie infami? Ovviamente banalizzo un po’, per far capire cosa intendo. Nel momento in cui il più importante concorso nazionale per inediti ti premia significa qualcosa di enorme, perché non c’è nessun interesse lobbistico a far vincere nessuno, c’è un comitato di sconosciuti che giudica altrettanti sconosciuti. E dai risultati letterari che mi hanno preceduto sembra che questo comitato sappia tremendamente cosa sta facendo. Mi fermo qui, perché finirei con il tessere lodi stucchevoli che potrebbero suscitare l’effetto contrario a quello voluto.
10) Ormai hai imboccato il percorso di scrittore: come lo vivi e cosa ti aspetti dal futuro?
È tutto molto forte: l’improvvisa apparizione del libro sugli scaffali delle librerie, le presentazioni, le prime recensioni. Cosa mi aspetto non lo so bene, spero sia l’inizio di un bel percorso. Il rapporto con Feltrinelli è stato inaspettato; avevo paura di trovarmi di fronte un’azienda grande e un po’ anonima, invece è stato come essere accolto all’interno di una famiglia. Quando sono andato a Milano mi hanno presentato tutti, in ogni settore. Persino Carlo Feltrinelli ha trovato il tempo di fare una chiacchierata con me… Insomma, che dire? Sono felice e frastornato. E la foto che ho scelto di mandarvi (al posto di quella del mio volume cartaceo) testimonia appunto le cose incredibili che posso vivere grazie a questo romanzo, in primis i rapporti inaspettati con i lettori. Mi è stata spedita da un reporter che sta seguendo le Farc in Colombia nel loro processo di smilitarizzazione. C’è dentro un miscuglio di elementi contrastanti: le armi del conflitto, la mano che impugna l’e-reader, il brand di una corporation, gli alberi della giungla e, spero, la magia della terra di Garcia Marquez…
Sono frastornato, l’ho già detto?



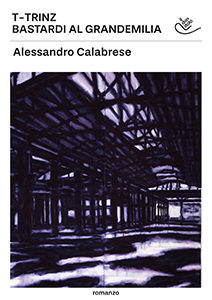


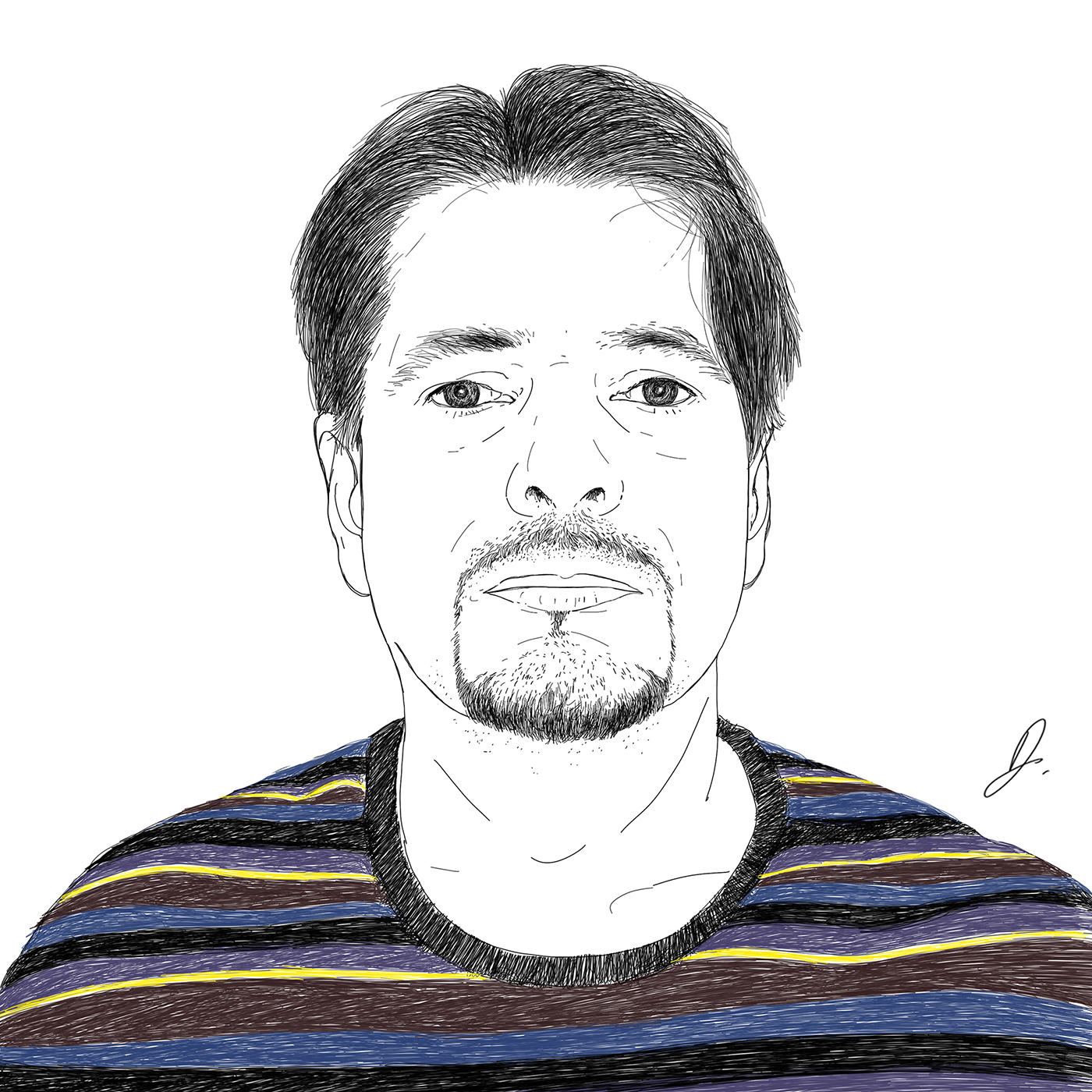
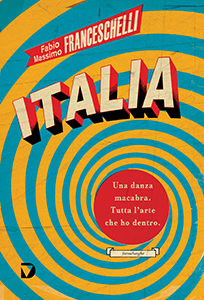




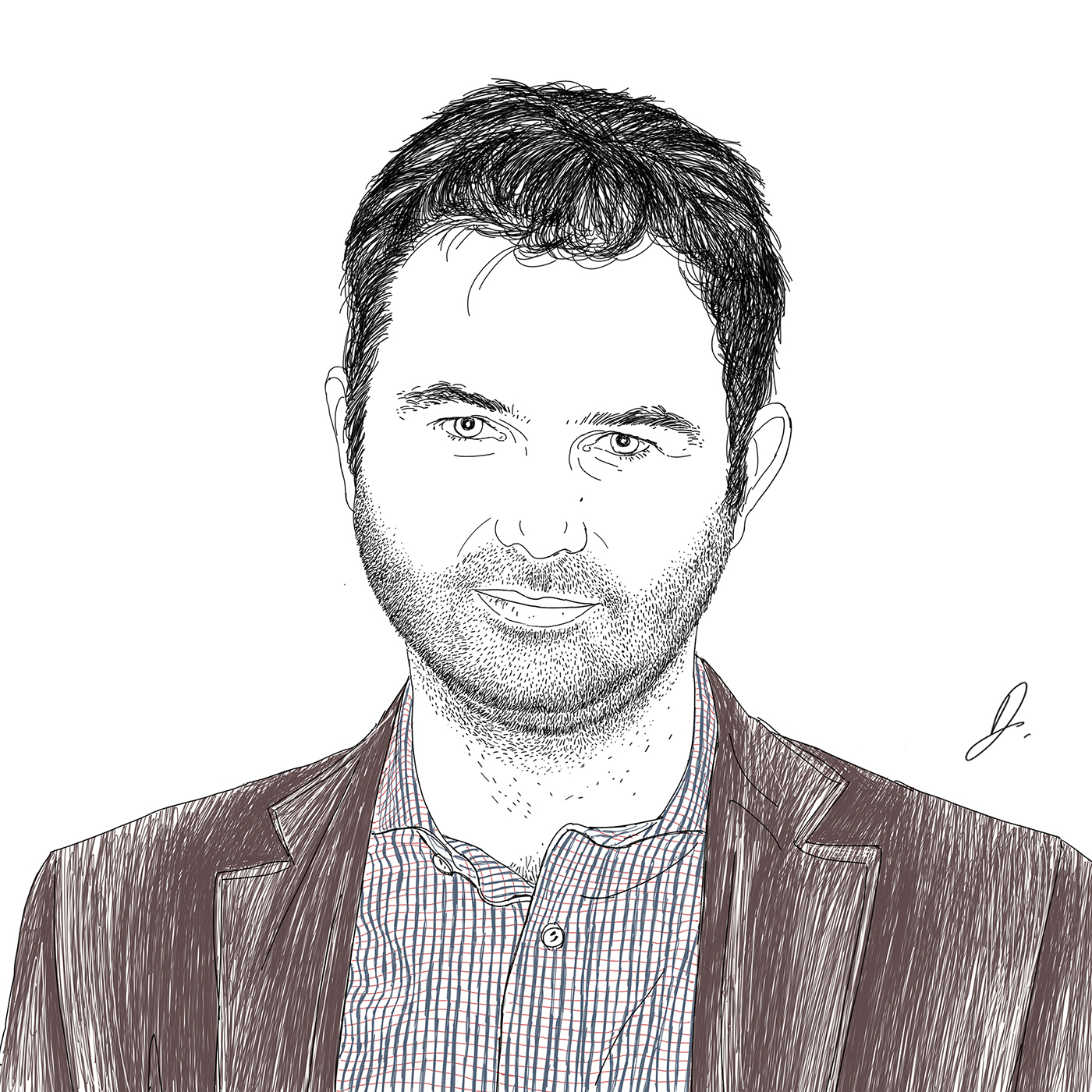













Visita il nostro canale Youtube
Visita la nostra pagina Facebook
Visita la nostra pagina Twitter
Visita il nostro profilo Instagram