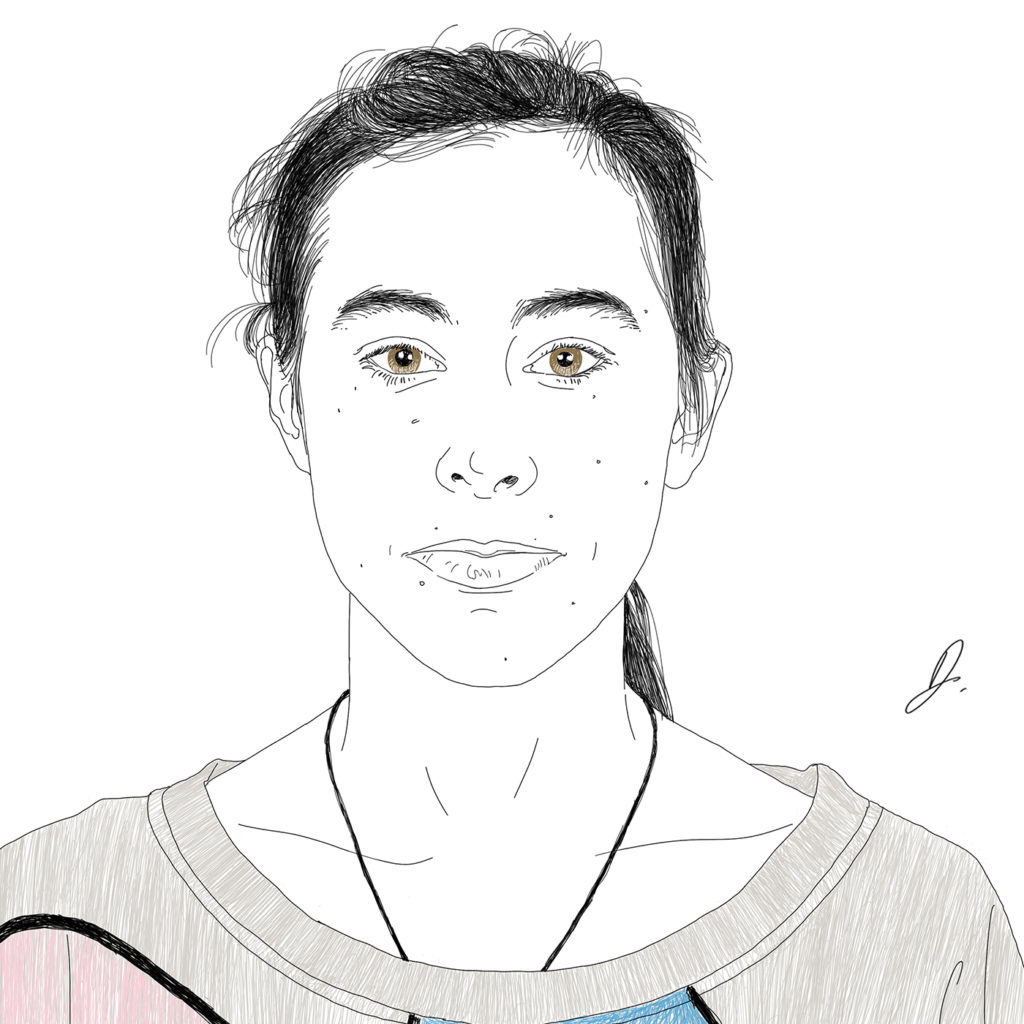
Intervista di Ella May – novembre 2016 – INEDITO
Illustrazione di Davide Lorenzon
Può succedere a chiunque, in qua e là nella vita, d’imbattersi in persone particolari, persone che magari non fanno nulla di eccezionale, eppure sanno rendere speciale tutto ciò che fanno.
Martina, a soli ventiquattro anni, è senza dubbio una persona così.
Lunigianese per nascita e milanese d’adozione, ha scelto di dedicarsi alle lingue e alle culture dell’Asia orientale, approfondite e vissute attraverso svariati viaggi che l’hanno portata a vivere per un intero anno a Taiwan.
Ma la sua inesauribile passione non si limita certo allo studio: Martina coltiva mille interessi diversi, tra i quali la scrittura riveste un ruolo di primo piano. Lei scrive da sempre, fin da bambina. E si sente.
Il romanzo con cui ha partecipato alla ventinovesima edizione del PIC, intitolato semplicemente Branchia, ha infatti ottenuto una meritatissima menzione speciale della giuria. Il suo testo, affascinante e profondo, dimostra una rara conoscenza dell’animo umano, sostenuta da una sensibilità talmente matura da spiazzare il lettore.
Branchia, sospeso tra realtà e fantasia, sa incantare e stupire, perché ci racconta con intensità toccante ciò che si agita al di sotto della superficie.
1) Fin dalle prime pagine sono rimasta colpita dalla varietà delle tue conoscenze: botanica, religione, filosofia, medicina, psicologia, zoologia, musica… E chi più ne ha, più ne metta. Perciò mi viene da chiederti: chi è Martina Renata Prosperi?
Una persona curiosa. Durante l’infanzia sono stata molto indecisa su cosa fare “da grande”; ho avuto voglia di diventare mille cose diverse, dal carabiniere alla biologa, dall’astronomo alla ballerina. Non esisteva una professione che non mi incuriosisse almeno un po’. Alla fine ho scelto di studiare le lingue, che sono strumenti per ascoltare le infinite esperienze altrui. E ho scelto di provare a scrivere, che è un modo per essere a mia volta ascoltata – o per ascoltare me stessa –, per passare parola, per dialogare.
2) Possiamo definire Branchia un metaromanzo? Può essere letto come “un romanzo nel romanzo”, oppure no?
In realtà non si tratta di “un romanzo nel romanzo”, ma di un romanzo che si sdoppia, quasi fosse una creatura dotata d’ombra o un’immagine leggermente fuori fuoco. Ginevra e Luca, due dei protagonisti, si trovano infatti a raccontare una storia che non “possiedono”, nel senso che non l’hanno inventata né voluta loro, una storia (quella di Branchia, appunto) che gli viene affidata per caso – anzi, per fortuna. Ma i personaggi di questa storia – e fra loro c’è appunto il “ragazzo con le branchie” – sono figure tanto vere (e tanto fittizie) quanto quelle dei loro apprendisti scrittori e delle persone “reali” cui si ispirano. Le due trame – e i personaggi che si muovono all’interno di esse – non vanno intese come “contenitore” e “contenuto”, perché sono intrecciate in un rapporto di compresenza. Branchia non va letto come una combinazione di scatole cinesi che ammicca alla logica del lettore, ma come un gioco di specchi e di riflessi incongruenti.
3) Una delle possibili chiavi di lettura poggia le basi sul tema della diversità: Branchia, Giulia, Alessia, Ginevra… Che sia per le condizioni fisiche o che sia per lo stato psicologico in cui si trovano, in qualche modo i tuoi personaggi sono tutti dei “diversi”. E tutti, nessuno escluso, portano avanti la loro lotta quotidiana.
In effetti non avevo mai pensato alla “diversità” dei miei personaggi in quanto tale. Voglio dire, ogni “diversità” è diversa dall’altra, e del resto non credo che al mondo esistano persone non-diverse: il contrario di diverso è uguale, ma uguale a chi? Branchia non ha i polmoni, Giulia e Alessia hanno un cuore difettoso, Ginevra ha uno stomaco riluttante, ma le figure che si occupano di loro non sono meno imperfette, o se preferisci, “diverse”: lo psicologo di Branchia, la madre di Giulia e Gabriel, Luca e Ginevra, non sono più liberi – né più felici – del paziente, dei figli o dell’amica che vorrebbero aiutare. La domanda da porsi, forse, non è “chi è diverso?”, bensì “chi è libero?”.
4) Questa domanda forse ti sembrerà un po’ strana, ma devo fartela: cosa rappresentano per te le tartarughe? Spuntano fuori di continuo, tra le pagine del tuo romanzo.
Le tartarughe, come il “ragazzo con le branchie”, sono l’incarnazione dell’irrazionale. Sono un dato di fatto (la vita è di per sé assurda: l’intento delle tartarughe che depongono le uova è utopistico, istintivo, seguito senza logica – e senza amore) ma sono anche una preghiera: la preghiera che quell’esistenza possa comunque iniziare, che il senso si possa costruire, che l’amore si possa volere. In Branchia le tartarughe sono i ricordi di una favola che Marie ha ascoltato da bambina, ma sono anche i talismani di legno che Giulia e Gabriel ricevono in dono da un musicista di strada. Sono simbolo di longevità e di lungimiranza, di pazienza, di forza. Sono la capacità di spingersi oltre, di attraversare gli oceani del dolore, ma anche di lasciarsi catturare – nella lunga traversata – da una rete dorata di luce, di inattesa e fuggevole gioia.
“Quando le tartarughe depongono le uova, non depongono mille vite. Depongono mille possibilità.”
5) Tra tutti i tuoi personaggi, qual è quello che ti somiglia di più?
Branchia, non ho dubbi. Branchia che abita nel mondo, eppure è separato dal mondo. Branchia che osserva gli altri vivere, ma senza trovare il modo di partecipare alla vita. Branchia, che è lo specchio nel quale ogni personaggio si guarda riflesso. Branchia che somiglia a tutti e a nessuno. Branchia che vorrebbe appartenere. Branchia che invidia l’amore. Branchia che libera, e che uccide. Branchia che inizia da me – proprio mentre nuoto come lui, nel grembo freddo e azzurro di una piscina – e che da me si separa, incarnando estremismi e trasgressioni che non mi appartengono ma che ho vissuto attraverso la sua storia, come un percorso di espiazione e di catarsi.
6) Come è nato questo romanzo? E perché hai deciso di mandarlo al Premio Italo Calvino?
Il romanzo è nato da un’immagine-simbolo: quella del ragazzo con le branchie. L’immagine dell’imperfetto, del prigioniero, dell’orfano che non appartiene a nessuno, a cui non spetta alcun rifugio né alcuna legittimazione a esistere. L’idea ha cominciato ad abitarmi fra la fine del liceo e il primo anno di università, mentre finivo di scrivere un altro lungo manoscritto, che è stato un po’ la palestra dei miei esperimenti. Nell’estate fra il primo e il secondo anno di università ho frequentato un corso di scrittura narrativa; a settembre ho iniziato a scrivere. Ho scritto tutte le mattine – a volte soltanto per mezz’ora, altre volte per un’ora o due – prima di uscire di casa e iniziare la mia vita “vera”, compresi i periodi di esami, lauree, partenze, Pasqua, Natale e Capodanno. In certi giorni mettevo insieme una frase, un paragrafo, una pagina. In altri giorni invece non riuscivo a scrivere nulla, oppure cancellavo la parte scritta il giorno prima. Sono andata avanti così per tre anni. Alla fine ho deciso di inviare il testo al Calvino perché desideravo un riscontro, e perché Giulia desiderava vivere.
7) Cosa ti aspettavi dal PIC e cosa ha significato per te partecipare?
Mi aspettavo una lettura, una scheda di valutazione, un incoraggiamento o un gesto di diniego. Dato il numero dei partecipanti, non mi aspettavo certo di arrivare in finale, anche se naturalmente ci speravo. Volevo scoprire se la mia scrittura avesse un qualche valore. Quando Marchetti mi chiamò, io non risposi; mi trovavo a Taiwan ed era quasi notte, non sapevo chi fosse al di là della cornetta e non volevo accollargli il costo di un’internazionale. Me lo disse mio padre, poco più tardi, su Skype: “Ha chiamato un signore del Premio Calvino…”.
Confesso: cominciai a ballare in giro per la stanza.
8) Sei davvero sicura di voler vedere pubblicato questo romanzo?
Certamente, mi piacerebbe. Non tanto, o non solo, per “vederlo pubblicato”, quanto per avere l’opportunità di lavorarci con altre persone, per imparare dal lavoro di editing. Pubblicare Branchia sarebbe per me un punto di partenza, la dimostrazione che le mie parole possono arrivare agli altri e portare loro quell’amicizia che io stessa chiedo alle mie letture. In fondo, per avere qualcosa da dire bisogna anche avere qualcuno a cui dirlo; Branchia è un biglietto in bottiglia che affido al mare. Forse andrà perso, ma mi piace pensare che qualcuno, trovandolo, potrebbe sentirsi fortunato e potrebbe fermarsi a raccoglierlo, per leggerlo.
9) Promettici che scriverai ancora.…
Per ora non ho mai smesso. Che si tratti di poesia, di racconti o di progetti con più ampio respiro, scrivere è per me un’attività di igiene quotidiana, il mio modo di dare ordine alle cose, per relativizzare le difficoltà della vita “vera”. Inoltre, l’idea a cui sto attualmente lavorando ha pure lo scopo d’iniziarmi a un nuovo aspetto dello scrivere: sto imparando che la scrittura può essere un percorso conoscitivo, perché non è sempre vero che si scrive di ciò che si sa, ma si scrive anche di ciò che ci rende curiosi, vigili, vivi.
Visita il nostro canale Youtube
Visita la nostra pagina Facebook
Visita la nostra pagina Twitter
Visita il nostro profilo Instagram