
Intervista di Ella May – aprile / maggio 2016
Illustrazione di Davide Lorenzon
Per Fabio Massimo Franceschelli, romano, classe 1963, la scrittura è senza dubbio una grande passione. Il suo curriculum è talmente ricco che diventa impossibile elencare in poche righe tutto ciò che ha prodotto. Laureato in storia e antropologia delle religioni, Franceschelli è sicuramente una delle penne più interessanti della drammaturgia nostrana. Redattore per la rivisita Perlascena, studioso, appassionato di cinema e teatro, ha dato prova di essere uno scrittore a tutto tondo guadagnandosi la finale della 28° edizione del Premio Italo Calvino. Il prossimo 19 maggio [2016] pubblicherà con Del Vecchio Editore il suo primo romanzo, intitolato semplicemente Italia; un testo capace di trasportarci fin dentro al cuore di una realtà parallela che riflette -e allo stesso tempo trasforma- il volto confuso del nostro Paese.
Anche lui il 13 maggio [2016] sarà ospite del Salone del Libro di Torino, all’interno dello spazio riservato ai talenti del PIC.
1) Partiamo proprio dalla parola “Italia”: questo nome accomuna il “Bel Paese” e la donna anziana che in qualche modo diventa il personaggio chiave del romanzo. In cosa si somigliano le tue due “Italie” e in cosa sono diverse?
Direi che sono complementari, che sono due immagini della “mia” Italia, ovvero di come mi rappresento la nostra nazione in questi anni. L’Italia narrata tra le corsie de “La Cattedrale” è una comunità allo sbando, travolta dal caos, vittima inerme di un meccanismo storico (di cui è essa stessa colpevole) che è già innescato e che nessuno può più fermare. Meccanismo che la porterà alla distruzione, e non parlo necessariamente della distruzione cruenta raccontata nel romanzo – che, anzi, sarebbe per certi versi liberatoria e produttiva almeno di un nuovo inizio – parlo semmai di una sorta di stagnazione, di rassegnazione alla decadenza che i più ormai nemmeno sono in grado di riconoscere. C’è ma nemmeno la si vede, perché per vederla ci vogliono strumenti culturali che stiamo perdendo. L’Italia personaggio, invece, è la vecchia Italia di cinquanta o più anni fa, che parla una lingua ormai morta, estranea a questo mondo ma che eppure vive, da qualche parte ancora vive grazie alla sua ostinazione (la “tigna”, nel romanzo). La sua lunga vita, la sua sorprendente sopravvivenza è il mio augurio per tutte quelle Italie chiuse nei nostri ricordi e che non ritroviamo più nel presente, ma rimpiangiamo e speriamo ancora di rivedere. Mi rendo conto che, detto così, il mio è un sentire alquanto nostalgico e conservatore.
2) Perché hai scelto di presentare singolarmente i personaggi della narrazione, prima di calarli a pieno nell’intreccio?
È stata una scelta che ha risposto a varie esigenze. In primo luogo una mia necessità di narratore di conoscere molto bene i personaggi, entrare nella loro testa, calarmi nei loro problemi e, di conseguenza, invitare il lettore a fare altrettanto. Poi, da vecchio autore teatrale quale sono, il gusto del monologo non lo perdo mai. Trovo il monologo lo strumento più efficace in direzione del realismo narrativo. Il monologo, inteso come flusso interiore di pensiero, è immediato, cioè senza mediazione dell’autore (o perlomeno con tale mediazione ridotta al minimo). Infine si è trattata di una scelta che risponde a un mio gusto di montaggio narrativo che definirei cinematografico.
3) Chiami “La Cattedrale” il centro commerciale che fa da sfondo all’azione, mescoli sacro e profano, provochi una vera e propria inversione dell’idea di divinità. È questo il fulcro della metafora? E fin dove arriva la tua metafora?
Domanda complessa, meritevole di un trattato. Provo a cavarmela così: l’ipermercato, il moderno centro commerciale, “La Cattedrale” del mio romanzo, non rappresenta un profano che si fa sacro. Al di là del luogo comune che innalza il denaro a nuovo Dio, direi che questi moderni templi del consumismo agiscono più sul versante del civico che su quello del religioso. Ma la cosa è ancora più sottile: se il religioso è sempre più un fatto privato e individuale e sempre meno pubblico, direi allora che il centro commerciale si candida a luogo deputato alla rappresentazione del “pubblico”, sia in direzione del civico (moderna agorà) che del religioso (spazio di ritualità e quindi chiesa, o cattedrale, desacralizzata). Il grande centro commerciale è la struttura che la moderna città non ha più e che le periferie non hanno mai avuto, è contemporaneamente il nuovo centro storico e la cattedrale cittadina, entrambi antichi spazi di rappresentazione pubblica. Tuttavia, direi che ormai ogni riflessione antropologica e sociologica sui centri commerciali è già vecchia, spazzata via da una società che si costituisce (e quindi si frammenta) sull’immaterialità della rete.
4) Ci spieghi il senso dei linguaggi che usi e del dialetto che hai costruito per la vecchia Italia?
Mi aspettavo questa domanda, me l’aspetto anche in future interviste, me l’aspettavo e la temevo. Il fatto è che non c’è chissà che lavoro dietro, il capitolo di Italia è stato scritto molto velocemente e senza pensarci troppo, appena in un paio di giorni, dopodiché ho lavorato sostanzialmente alla coerenza grammaticale e sintattica del suo dialetto. Ho sempre avuto difficoltà tanto con le lingue straniere quanto con i dialetti italiani. Non li capisco i dialetti italiani, soprattutto quelli meridionali, alla fine mi restano in testa solo una serie “di ì, ù e ò accentate” (cito dal romanzo). E questo è il dialetto d’Italia, condito da qualche buffa espressione popolare di chissà quale provenienza, da improbabili prestiti dal latino, dal greco e addirittura dall’inglese. Mario Marchetti del Premio Calvino ha amato molto il “becose” in luogo di “perché”, che ovviamente va letto così come è scritto e con l’accento che cade sulla prima vocale. Ho cercato un dialetto immaginario ma al tempo stesso riconoscibile, una lingua che non esiste se non nella mia mente, come probabilmente non esiste, se non nella mia mente, Italia, la vecchia Italia, non esiste più o addirittura non è mai esistita.
5) I ritmi della narrazione: dall’analisi sociologica all’emotività, dalla singolarità alla collettività. Ci sono sia il cinema che il teatro dentro il tuo romanzo.
Il ritmo della mia narrazione è debitore di un preciso formalismo cinematografico. Tutto ha un andamento spiraliforme e centripeto (complimenti a chi ha concepito la copertina: ha colto perfettamente questa struttura), tutto tende a passare gradualmente dall’esterno all’interno, dall’aperto al chiuso, dal calmo al caotico, dal pensiero all’azione e, infine, visto che nomini il teatro, direi anche dal narrativo al teatrale, il teatrale della “pièce bien faite”. Se fosse musica rock parlerei di struttura post-rock, rilassante all’inizio e culminante in un terrificante “wall of sound”. Se fosse cinema direi che Tarantino è stato per me un buon modello. Il cinema, poi, è presente anche per le esplicite citazioni di Antonioni con Zabriskie Point, di Hitchcock con The Birds, di Monicelli con Un borghese piccolo piccolo. Diciamo che ho voluto scrivere con una telecamera in mano.
6) Tu, in questa giostra di personaggi e di vicende, da che parte stai? Sempre che tu stia da una parte piuttosto che dall’altra, sempre che esista una parte piuttosto che un’altra.
Sono italiano e quindi sto un po’ dappertutto. Sono un po’ Sabelli e un po’ Strangio, un po’ Mario e un po’ Conte, e sono anche la vecchia Italia e la giovane Luana e il sindacalista Sammaroni e così via. Sono un po’ tutti i miei personaggi. Ma la tua domanda me ne porta un’altra: c’è del moralismo da parte dell’autore? Non lo so, spero tanto di no, ho paura di sì. Attendo i commenti dei futuri lettori. Io ho provato a narrare “dall’alto”, tenendomi molto distante e senza parteggiare, ma non so se ci sono riuscito.
7) Tu scrivi da sempre per il teatro: cosa ti ha spinto a sperimentare un’altra forma narrativa e a farlo attraverso il Premio Italo Calvino?
Da ragazzo scrivevo brutte poesie, da giovane, dopo la laurea, ho affrontato la saggistica, nello specifico l’antropologia culturale e la storia delle religioni. Da vent’anni scrivo drammaturgia e negli anni passati ho prodotto anche tanta critica, su varie riviste. Ora è il momento della narrativa. Direi che la distinzione tra i generi non mi piace e che secondo me uno scrittore non deve mai chiudersi nei propri comodi territori.
Riguardo al Calvino la risposta è semplice: con gli anni ormai si è meritatamente imposto come il principale premio letterario italiano per autori esordienti; è la vetrina più seguita dalle case editrici e nello stesso tempo anche il premio che dà maggiori soddisfazioni al partecipante, a cui viene comunque garantito il ritorno di un’accurata scheda di lettura.
8) Parlaci del tuo percorso di pubblicazione, un cammino non del tutto nuovo per te, anche se questo è il tuo primo romanzo.
Bella esperienza, ma estenuante: ho iniziato a scrivere Italia nel maggio 2013, l’ho pubblicato esattamente tre anni dopo. Scrivendo sostanzialmente teatro sono abituato a tempi molto più veloci. Riguardo all’editing, ne approfitto per dichiararmi molto fortunato ad aver incontrato una editor come Vittoria Rosati Tarulli, che ha amato il mio testo e lo ha saputo sfrondare con intelligenza e sensibilità. Lavorare con lei mi è piaciuto molto.
9) Preferisci il teatro o la narrativa? In quale territorio ti senti più a tuo agio?
Di teatro ne ho scritto tantissimo e mi piacerebbe molto realizzare nuovi progetti nell’ambito della narrativa, ma non sono un grafomane, scrivo se e quando sono ispirato e, soprattutto, se ho qualcosa di “urgente” e interessante da dire. Il presentarsi di entrambe le condizioni è evento abbastanza raro, staremo a vedere.
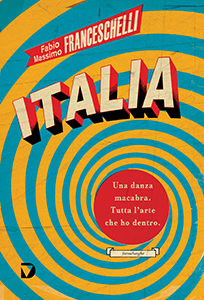
Visita il nostro canale Youtube
Visita la nostra pagina Facebook
Visita la nostra pagina Twitter
Visita il nostro profilo Instagram